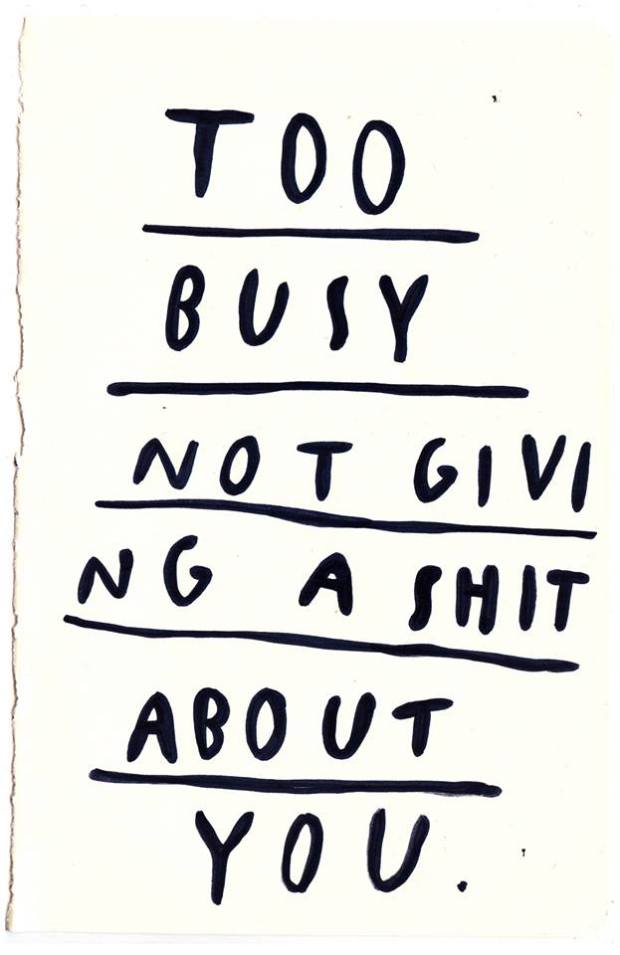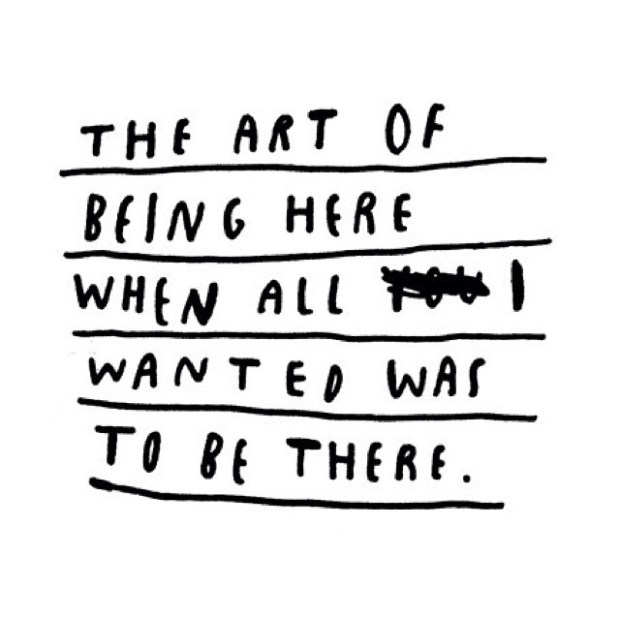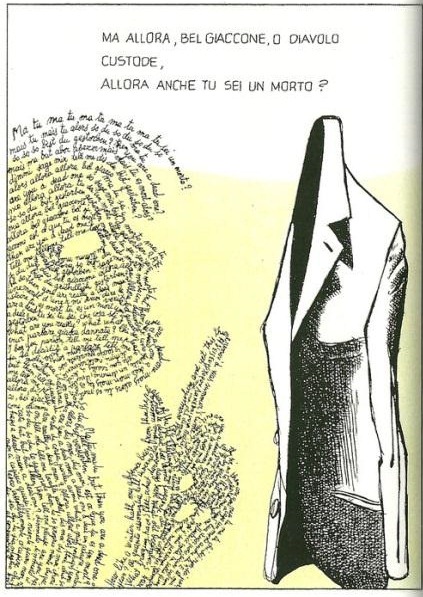C’era una volta, tanto tempo fa, una fiaba, ma ho dovuto ammazzarla. Senza esitazioni e ripensamenti. Un colpo netto, come uno squarcio nella pancia del lupo cattivo, come la strega chiusa nel forno a bruciare, morta, una volta per tutte, come un cartone animato sciolto nella salamoia. Questo articolo è quel che resta di un’immersione nelle favole per soli adulti, lette e vissute, è stato scritto un paio d’anni fa, sotto l’effetto allucinogeno di un libro di fiabe tradizionali, reinterpretate da scrittori contemporanei. Si tratta di uno di quei libri a cui io ho fisicamente voluto bene, al punto da portarmelo dietro nello zaino anche una volta finito, per poterne rileggere dei brani, l’ho tenuto a lungo sotto il cuscino e ho avuto cura di non affidarlo alle mani sbagliate. Era un periodo della mia vita in cui anche io pensavo di essere la protagonista di una fiaba per adulti, dove non ci sono colpi di fortuna, ma solo imprevisti, non ci sono magie, ma solo illusioni. Ero a Parigi, lavoravo in redazione, lasciavo una casa e ne prendevo un’altra e cercavo disperatamente un lieto fine per la mia fiaba personale. Ho voluto riprenderlo e conservarlo tra queste pagine, perché in quelle storie c’è una parte di me, quella che, anche nella più ordinaria delle routine, non vuole rinunciare a un po’ di polvere di fate e a un briciolo di illusione. Forse, come diceva Calvino, la fantasia è un posto dove ci piove dentro, o forse aveva ragione Gianni Rodari, la fiaba è semplicemente il luogo di tutte le ipotesi: possiamo scegliere quella che ci piace di più, anche se non è vera.
Ispirandosi al lato oscuro delle fiabe dei fratelli Grimm e di Hans Christian Andersen, non sono pochi gli autori contemporanei che si sono cimentati con la reinterpretazione dei racconti d’inverno più classici, dove la fantasia sembra votarsi al più disincantato realismo, alla normalità più eccezionale e dove il luccichio della polvere di stelle lascia il posto al viale del tramonto e alla quotidianità, preferendo ai caratteri in bianco e nero creature dalle personalità screziate e ambigue.
André Breton era convinto che la miniera d’oro delle fiabe non fosse del tutto esaurita, che ci fosse ancora uno scampolo di racconto da scrivere per i più grandi. Le fiabe tristi, quelle più sporche, meno innocenti. Sembra fargli eco, almeno 50 anni dopo, Maurice Sendak, illustratore e scrittore, originario di una famiglia di ebrei polacchi rifugiatisi negli Stati Uniti durante la Seconda Guerra mondiale, morto qualche anno fa. “Mi rifiuto di alimentare questa cazzata dell’innocenza”, aveva dichiarato in un’intervista, ricalcando la stizza dei fratelli Grimm, illustri filologi e studiosi, erroneamente considerati solo scrittori di favole. Autore de Nel paese dei mostri selvaggi, Sendak era a suo agio con i grumi di paura, il dolore, i cuori spezzati, il sangue, che hanno fatto delle favole quasi un antidoto ai sentimenti umani più cupi o, come diceva Jack Zipes, studioso dell’antropologia del folklore, “meri strumenti per vincere il terrore dell’umanità con l’aiuto di una metafora”.
Streghe post-strutturaliste
“Era in grado di addomesticare il terrore, attraverso la poesia e l’estensione del linguaggio“, così scriveva Kurt Vonnegut di Anne Sexton, poetessa e scrittrice inglese, nata nel 1928, che tuttavia non riuscì ad addomesticare le sue di paure, suicidandosi nel 1974 all’età di 45 anni. Con Transformations (1971), Anne Sexton si guadagnò la reputazione di “strega post-strutturalista”, reinterpretando 17 fiabe dei fratelli Grimm. Qui il “vivere felici e contenti” si muta nell’ennesimo dovere, una stasi impossibile da sopportare. La mamma di Raperonzolo è una vecchia donna dal cuore spezzato, la Bella Addormentata delude le aspettative del suo pubblico soffrendo di insonnia e la Cenerentola e il principe sono gli unici a meritarsi un lieto fine, finendo “felici e contenti” ma come due statue in un museo, senza darsi neanche più la pena di discutere, nemmeno per la cottura di un uovo. Ai matrimoni smaglianti, Sexton preferisce l’amore imperfetto, come nella storia ispirata alle dodici principesse che scappano dal castello per danzare tutta la notte, un’immagine che scivola in quella di una donna paralizzata che non vuole rinunciare ad andare nei caffè il sabato sera con suo marito e guardare gli abbracci degli amanti nella pista.
Una lucida consapevolezza che Sylvia Plath, poetessa americana, morta suicida nel 1963 a 30 anni, ha scelto deliberatamente di lasciare fuori dal suo unico libro per bambini The Bed Book, una collezione di poemetti bislacchi sul letto, da quello fatto per i gatti a quello per gli acrobati fino al giaciglio ideale, simile a un sottomarino o un jet con direzione Marte, provvisto di zanzariere per le stelle cadenti. Una spensieratezza che ricorda gli alter ego fiabeschi di Italo Calvino, che creò le figure del barone rampante Cosimo Piovasco di Rondò, salito sugli alberi senza scendervi mai più per un supremo atto di disobbedienza, del cavaliere inesistente e del visconte dimezzato, negli stessi anni in cui s’immergeva nel colorato oceano delle fiabe italiane.
Sabotatori di fiabe
“Mi piace ogni cosa che luccica”, diceva Angela Carter. Con La camera di sangue (1979), rinunciando alla definizione di “favole per adulti”, la scrittrice e giornalista inglese ha stravolto gerarchie e stereotipi, facendo di Cappuccetto Rosso una giovane donna per nulla intimorita di dormire tra le zampe del lupo nel letto della nonna. È a lei, vera e propria sabotatrice di fiabe, che Kate Bernheimer, statunitense, creatrice del magazine Fairy Tale Review, ha dedicato l’antologia di fiabe contemporanee My mother she killed me, my father he ate me, una collezione di 40 nuovi racconti riscritti da autori come Neil Gaiman, Joyce Carol Oates, Ludmilla Petrushevskaya e Michael Cunningham.
Vladimir Propp e le sue 31 sedicenti inalterabili funzioni della fiaba si arrendono davanti a queste favole intrise di disincanto e malinconia. Ci sono boschi sì ma anche squallide cucine di fast food, cortili polverosi e abbandonati, odore di vecchiaia, retrobottega poveri. La sirenetta di Andersen finisce prima impagliata nella Mermaid Parade di Mudpuddle Beach, dove ogni anno decine di folli sirene muoiono soffocate dall’aria, e poi ritorna umana in una delle fiabe più intense di tutto il libro, dove è la sfortunata metà di una coppia, che assiste alla crescente attrazione del suo uomo per una creatura ben meno eterea e molto più terrestre.
“Soggetto 525, donna caucasica sulla ventina, arrivata nel reparto pronto soccorso intorno alle 23 presentando sintomi di un’acuta patologia psicotica”, così Cenerentola debutta nell’antologia mentre Biancaneve è la fantasia erotica di un manipolo di nani che condividono un loft e, tra lattine di birra, tortilla chips e PlayBoy, aspettando l’arrivo della donna che ridarà loro la dignità di uomini.
“L’effetto scioccante della bellezza è la caratteristica di ogni favola”, ha scritto lo studioso di folklore Max Lüthi. Qui i personaggi non sembrano più in grado di sostenere questo shock. Svanito l’effetto dell’incantesimo, principi e principesse tornano individui normali, sfiancati dallo scontro quotidiano, protagonisti loro malgrado di favole postmoderne, dal finale ammaccato. La fiaba si arrende rassegnata alla realtà. E la realtà, anche quella più cupa ordinaria, sembra non voler rinunciare al suo briciolo di illusione.
Soundtrack: Searching for Heaven, The Drums
Images (cc) marvelous Elena Kalis on Flickr