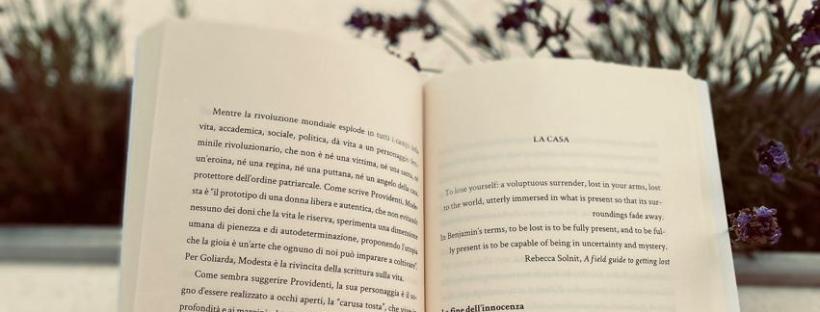Ci sono libri, e storie, che stanno là, in uno scaffale della libreria, in un angolo del soggiorno. Sai di cosa parlano, ti sembra quasi di averle già lette, perché sono opere conosciute, il momento di prenderle in mano viene sempre rimandato. Poi, arriva anche il loro turno e, per una strana forma di serendipità o di corrispondenza con le ere della tua vita, quasi sempre il momento è quello giusto.
Così, a un mese dalla nostra partenza, tra valigie da fare, documenti e preparativi, quell’algoritmo analogico che è la letteratura, che da un libro conduce a un altro, senza soluzione di continuità, mi ha messo tra le mani “Revolutionary Road” di Richard Yates, acquistato d’istinto in quel luogo mitico che è la libreria I volatori a Nardò e terminato proprio ieri.
“Capolavoro ineguagliato”, come viene definito dalla critica, da cui Sam Mendes ha tratto un film apprezzato e di successo con Kate Winslet e Leonardo Di Caprio. La storia, in poche righe, è questa: siamo nel 1955 e i Wheeler, una giovane coppia con figli, sentendosi intrappolata nel quotidiano di una periferia nel Connecticut, a qualche miglio di treno da New York, prende la decisione di ritornare a sentire l’ebbrezza della vita trasferendosi a Parigi. L’esistenza, il logorante e incessante chiedere della quotidianità, li riacciuffa e, piccolo spoiler, non va a finire bene.
“Non possiamo continuare a fingere che è la vita che volevamo…avevamo dei progetti, tu avevi dei progetti… guarda noi due, siamo cascati nella stessa ridicola illusione… l’idea che devi ritirarti dalla vita, sistemarti nel momento in cui hai dei figli…era una bugia”, dice April Wheeler, “Per anni ho pensato che noi condividessimo un segreto: che noi due saremmo stati meravigliosi nel mondo”.
In questa girandola di personaggi tesi a mantenere uno status quo invidiabile, solo John Givings, matematico e figlio dell’agente immobiliare, un cinquantenne che ha subito 37 elettro-shock e vive internato nella clinica di Greenacres, intuisce e sente risuonare nelle corde del cuore il desiderio di cambiamento dei Wheeler: “Il vuoto disperato… Ora l’ha detto, molte persone sono coscienti del vuoto ma ci vuole un gran fegato per vedere la disperazione”.
Quanto questo libro abbia avuto un’eco in questo mese di preparativi è facile capire. I compromessi della vita a due, l’idea di avere sempre e solo rinunciato a qualcosa da qualche anno a questa parte, la sensazione che Parigi, in un certo qual modo, avrebbe rimesso tutto a posto. E, d’altro canto, il conforto delle piccole abitudini, delle distanze che si riducono, del sentirsi al riparo da un’incontrollabile idea di mondo che se ne va per conto suo, mentre ci lascia qui.
Si può avere le farfalle nella pancia prima di incontrare una città? Si possono avere i brividi al pensiero di prendere un treno metropolitano? Avere le mani che tremano facendo un check-in?
L’ultima volta che ho messo piede in Francia è stato nel mondo di prima. Appena prima dello scoppio della pandemia, negli ultimi mesi del 2019. Un mese di giugno caldissimo, una gravidanza appena sbocciata, il pensiero che sarebbe stato solo un arrivederci, che ci saremmo visti regolarmente, come ci si dice tra vecchi amici che stanno solo cambiando quartiere. “Ci sentiamo”, “poi ci aggiorniamo”, “alla prossima”.
La prossima volta non c’è stata. La nascita di due bambini, un mondo stravolto da un virus, cambi di lavoro, case e prospettive, e un’insolita paura, di quelle che non provavamo da tanto tempo, a prendere un biglietto aereo. “Adesso non è il momento”, “con loro come facciamo?”, “e se succede qualcosa?”. Nel frattempo, la ricerca spasmodica di una casa, letterale e metaforica, di un luogo dove sentirsi protetti e al sicuro. Il tentativo, ogni giorno da ricominciare, di rimettere tutto in piedi, in equilibrio, di avanzare, fosse anche di un passo solo. Una sosta doverosa per dirsi che di strada ne era stata fatta tanta, che ci si poteva sedere e respirare un po’, e ricordarsi che “fermarsi è correre ancora di più”.
E poi, un giorno, in una primavera piovosa come quella di quest’anno, ci siamo decisi a prendere un volo, a regalarci quello che per noi significa davvero un ritorno a casa.
Qualche giorno fa una persona mi ha detto: “Vedrai che i luoghi ti saluteranno come dei vecchi amici”. Ho pensato che rimettere piedi a Parigi sarebbe stato come sentirsi dire un “come va?” da una vecchia conoscenza. Una di quelle domande che vogliono dire tante cose. Che vogliono dire, se hai voglia, mi puoi raccontare tutto, o niente. Come sono andati questi anni? Hai trovato quello che cercavi? Quanto hai perso alle scommesse? Quanti progetti infranti? E quanti e quali incendi hanno preso fuoco dalle ceneri? Quante medaglie? Quanti silenzi?
Poi i francesi, quando dicono “ça va?”, raramente vogliono sapere davvero come stai. È una delle prime cose che s’impara mettendo piede in Francia: a rispondere con un altrettanto “ça va, et toi?” e a chiudere i convenevoli, senza approfondire.
A domani, Paris. Qui non vediamo l’ora.
Foto di copertina: “View from Notre-Dame”
Paris, 1955.
Ernst Haas