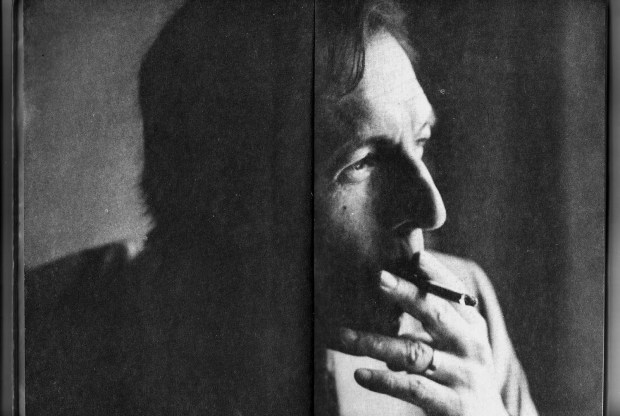Sbarcato a Praga, senza alcun appoggio, senza l’indirizzo di un hotel in tasca, un conoscente che lo aspetti a casa, pochi soldi nel portafoglio, sperduto nella fredda stazione mitteleuropea, Albert Camus si sente gonfio d’uno strano sentimento di libertà, perché le sue due valigie non pesano ormai più di tanto, il braccio è leggero, il passo veloce. Poco importa della solitudine, della paura di ritrovarsi in un paese sconosciuto, dove anche la lingua, il biglietto del tram, il gusto dei piatti tipici, si ignora, poco importa dell’apatia che sopraggiunge talvolta in quei viaggi solitari, in fondo “ogni paese dove non mi sono annoiato non mi ha mai insegnato niente”.
Camus scrive del suo arrivo a Praga, ma anche delle sue notti algerine, di sua madre silenziosa, della scoperta del sole italiano, dei cafè chantant spagnoli, nel suo primo libro L’envers et l’endroit, letteralmente Il rovescio e il diritto, una raccolta di cinque saggi autobiografici, scritti tra il 1935 e il 1936 e pubblicati nel 1937 ad Algeri, in pochissimi esemplari. Composti a soli 22 anni, rimasti introvabili a lungo, Camus ne ha consentito una nuova edizione solo dopo vent’anni, accompagnandoli con una prefazione, una vera e propria dichiarazione di poetica e di linea di pensiero.
“Nonostante viva adesso senza la preoccupazione del domani, quindi da privilegiato, non sono capace di possedere. Di tutto quello che ho, e che mi è stato offerto senza che io l’abbia cercato, non posso tenere nulla. Non per generosità, ma in virtù d’un’altra specie di parsimonia: sono avaro di quella libertà che sparisce non appena comincia l’eccesso delle proprietà. Il maggiore dei lussi non ha mai cessato di coincidere per me con una certa nudità. […] Non ho mai saputo abbandonarmi a quella che chiamano ‘vita d’interni’ (che spesso si rivela essere l’esatto opposto della vita interiore); la felicità cosiddetta borghese mi annoia e mi spaventa”.
Jusqu’où ira cette nuit où je ne m’appartiens plus ?
L’esperienza, la proprietà, la ricchezza, sono sopravvalutate, scrive Camus. Pochi sanno che, almeno una volta nella vita, bisogna aver perso tutto, restare da soli, andarsene. E offrirsi, ogni tanto, una prospettiva nuova, consentirsi un domani diverso, imprevedibile. La possibilità di perdersi, di fermarsi ad ascoltare il rumore della notte su un marciapiede arabo di Algeri, farsi sconvolgere dalla semplicità della cattiveria, insozzarsi per sempre della crudeltà e dello squallore delle periferie occidentali, la libertà di lasciarsi intimorire, spaventare dall’ignoto, da nuove destinazioni, chiedere alla propria madre “A cosa pensi?”, “A niente”, e sapere che è vero.
A poco più di vent’anni, Camus intravede già nei caffè e nei giornali un elemento importante del viaggio. Qualche tempo fa, avevo letto in un articolo che l’odore del caffè e quello della carta stampata sono in grado di far sentire a casa chiunque. Fa parte dei trucchi del viaggiatore, quelli che si adoperano per mitigare la solitudine, per rinfrancarsi lo spirito. Ce n’è uno, classico, secondo Camus, quello di fare quattro passi in un museo, a tempo perso, continuare le proprie flânerie tra tele e sculture, per trasformare l’angoscia in malinconia. Trucco collaudato dallo scrittore francese, e tra i preferiti di chi ha vissuto a Parigi, aggiungo io. E poi c’è quello di infilarsi in un bar, di sedersi al bancone e svuotare i pensieri in una tazza di caffè, rifugiarsi in “un luogo”, scrive Camus, “in cui si può tentare di avvicinarsi agli altri, che ci permette di mimare in un gesto familiare l’uomo che eravamo a casa, e che, a distanza, ci sembra uno straniero”.
“Perché il pregio del viaggiare consiste nella paura. Spezza in noi una specie di apparato scenico interno. Non è più possibile barare – mascherarsi dietro ore di ufficio e di cantiere (quelle ore contro cui protestiamo tanto e che ci difendono con tanta sicurezza dalla sofferenza di esser soli). Per questo avrei sempre voglia di scrivere romanzi i cui personaggi dicano: ‘Che sarebbe di me senza le ore di ufficio?’ o anche: ‘Mia moglie è morta, ma per fortuna ho un gran fascio di atti da redigere per domani’. Il viaggio ci toglie questo rifugio. Lontano dai parenti, dalla lingua, strappati a tutti i nostri sostegni, privi delle nostre maschere (non si conoscono le tariffe dei tram ed è tutto così), siamo completamente alla superficie di noi stessi. Ma sentendoci male all’anima, restituiamo ad ogni essere, ad ogni oggetto, il suo valore di miracolo. Una donna che balla senza pensare, una bottiglia sul tavolo intravista dietro una tendina: ogni immagine diventa simbolo.”
Tornando a Praga, nelle fredde strade della capitale, Camus ricorda i suoi caldi viaggi in Italia, “terra fatta a immagine e somiglianza della mia anima”, le vigne profumate, le lunghezze dei cipressi, i nodi degli ulivi, l’odore forte dell’albero di fichi, le piazze ricolme d’ombra sotto un sole indifferente, il flauto acuto e tenero delle cicale, il silenzio che nasce dal rincorrersi lento delle giornate. Mettere a fuoco il linguaggio di un orizzonte nuovo, sentire finalmente che si accorda con il nostro, e non perché trovi una risposta alle nostre domande, ma perché queste domande le rende inutili.
Camus rivendica il diritto all’indifferenza, sprezza la ricerca della felicità a tutti i costi e a questa preferisce l’essere cosciente, la presenza a se stessi, il vivere il buono e il cattivo tempo, sperimentare tutto, il rovescio e il diritto di ogni momento, sfuggire il sonno, “avevo voglia d’amare come si ha voglia di piangere”, come qualcosa di forte e naturale, a cui bisogna solo lasciarsi andare. La sua indifferenza, assicura, è molto simile alla compassione, a un’empatia panica con il creato, con la bellezza dei paesaggi, del moto delle onde, del vento tra le spighe di granturco, con l’atteggiamento freddo della natura, che raramente s’accompagna ai moti dell’animo umano e che, proprio per questo, sembra comprenderli tutti.
“Adesso non desidero più di essere felice ma solo d’essere cosciente. Tra questo diritto e questo rovescio del mondo, non voglio più scegliere”.
Soundtrack: Scott Matthews, Myself Again
Images © Emiliano Ponzi